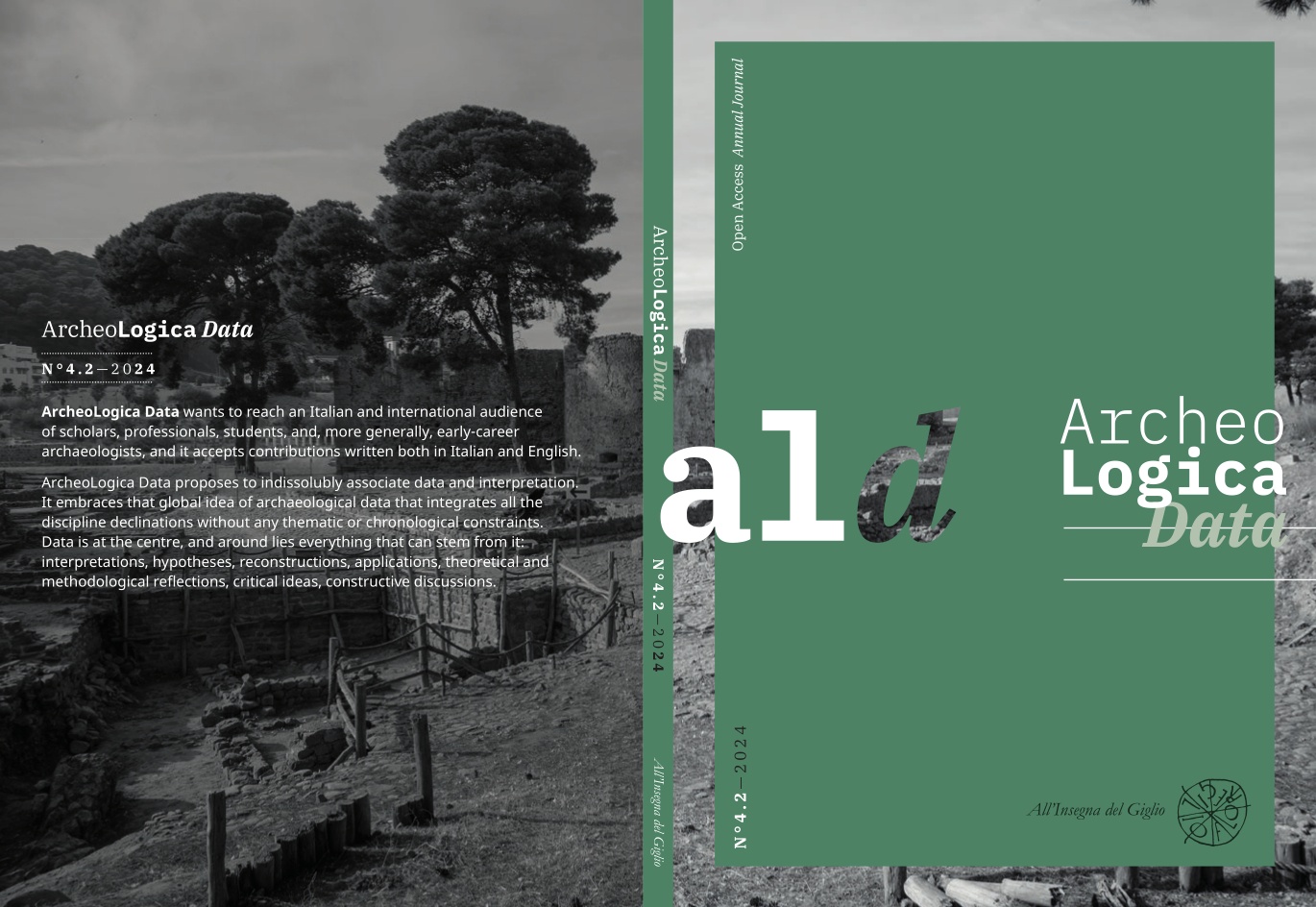ArcheoLogia Data 4.2/2024
ArcheoLogica Data è una rivista annuale Open Access (OA) che offre a ricercatori e professionisti la possibilità di pubblicare articoli Open Access con l’obiettivo di contribuire alla condivisione dei “raw data” provenienti da qualsiasi tipo di indagine archeologica – scavo, survey, remote sensing, indagini geognostiche, analisi archeometriche, studio di materiali, ecc… – e di sostenere la scienza collaborativa, senza limitazioni cronologiche o territoriali.
È con grande piacere che presentiamo il volume degli atti della XVI edizione dell’European Meeting on Ancient Ceramics (EMAC2023), tenutasi a Pisa dal 14 al 16 giugno 2023. Questo evento, ormai consolidato come punto di riferimento internazionale per la comunità scientifica archeologica e archeometrica, ha avuto luogo presso l’Aula Magna del Polo Piagge dell’Università di Pisa. EMAC2023 ha riunito studiosi e studiose provenienti da tutto il mondo, offrendo un’importante piattaforma di dialogo e confronto scientifico sui temi della ceramica antica. La conferenza si distingue per la capacità di integrare approcci scientifici e umanistici allo studio della ceramica, esplorando aspetti che spaziano dalla produzione, distribuzione e uso, fino alla conservazione e alterazione post-deposizionale. Questa edizione ha dato particolare rilievo a contributi metodologici innovativi, presentando i recenti sviluppi analitici e scientifici che stanno arricchendo il settore archeometrico. Tra i lavori inclusi in questo volume, si segnala la presentazione del database FACEM (Fabrics of the Central Mediterranean), illustrata da Borgers et al. FACEM, nato per la raccolta e condivisione open access di dati sugli impasti ceramici greci, punici e romani, rappresenta oggi una risorsa di primaria importanza per la ricerca interdisciplinare. La disponibilità di questa banca dati, accessibile a livello internazionale, testimonia l’impatto della digitalizzazione nella diffusione della conoscenza archeometrica. Di particolare interesse è anche il contributo di Menchelli e colleghi, che hanno indagato la produzione ceramica della regione Tosco-Ligure adottando un approccio petrografico diacronico. Il loro studio, che valorizza la geodiversità della regione e promuove un approccio sostenibile di “archeometria green”, si è posto l’obiettivo di minimizzare il campionamento, favorendo il riutilizzo dei campioni già esistenti. Tale ricerca, un esempio concreto di sostenibilità in archeometria, offre un modello metodologico che coniuga rigore scientifico e attenzione alla tutela del patrimonio.
Nel campo dell’analisi chimica non distruttiva, Guerrero Rivero et al. presentano un’applicazione della fluorescenza a raggi X portatile (pXRF) per lo studio di ceramiche coloniali provenienti dal Nord Africa e dalla Penisola Iberica. Questo contributo, che ha esaminato ceramiche provenienti da siti archeologici chiave, evidenzia l’efficacia della pXRF nel preservare l’integrità dei reperti, promuovendo allo stesso tempo una maggiore comprensione delle dinamiche commerciali e delle influenze culturali tra le comunità. Il contributo di Russo et al. porta nuovi dati sull’artigianato neolitico del sito di Rio Tana in Abruzzo. Attraverso un’analisi petrografica preliminare, il gruppo ha identificato le caratteristiche delle materie prime e delle tecniche di produzione, offrendo preziose informazioni sulle pratiche artigianali dell’epoca. Lo studio di Russo et al. costituisce un significativo approfondimento sul controllo della temperatura e sulle tecnologie di cottura impiegate dai vasai preistorici. Un altro contributo significativo, a cura di Sara Rojo Muñoz et al., esplora il ruolo della Valle dell’Albegna, situata nel territorio nord-occidentale di Vulci, come importante distretto agricolo etrusco specializzato nella produzione vinicola. Attraverso l’analisi delle anfore da trasporto provenienti da Marsiliana d’Albegna e Doganella, così come da siti portuali correlati come Lattara ed Emporion, lo studio ha identificato cambiamenti nella produzione di anfore tra il VI e il V secolo B.C.E. L’indagine archeometrica ha fornito prove convincenti del commercio di vino etrusco verso le coste celtiche e iberiche, mettendo
in evidenza le interazioni socio-economiche e culturali tra le regioni.
Grazie anche ai contributi raccolti in questo volume, EMAC2023 ribadisce il proprio ruolo come appuntamento centrale per l’avanzamento della conoscenza sul patrimonio ceramico, stimolando una sempre maggiore collaborazione interdisciplinare.
Desideriamo rivolgere un ringraziamento speciale ai membri dei comitati scientifico e organizzativo, il cui impegno è stato essenziale per il successo di questo evento, e a tutti i partecipanti per i loro preziosi contributi. Auspichiamo che questo volume sia fonte di ispirazione e stimoli ulteriori sviluppi nella ricerca e nella valorizzazione del
patrimonio ceramico.